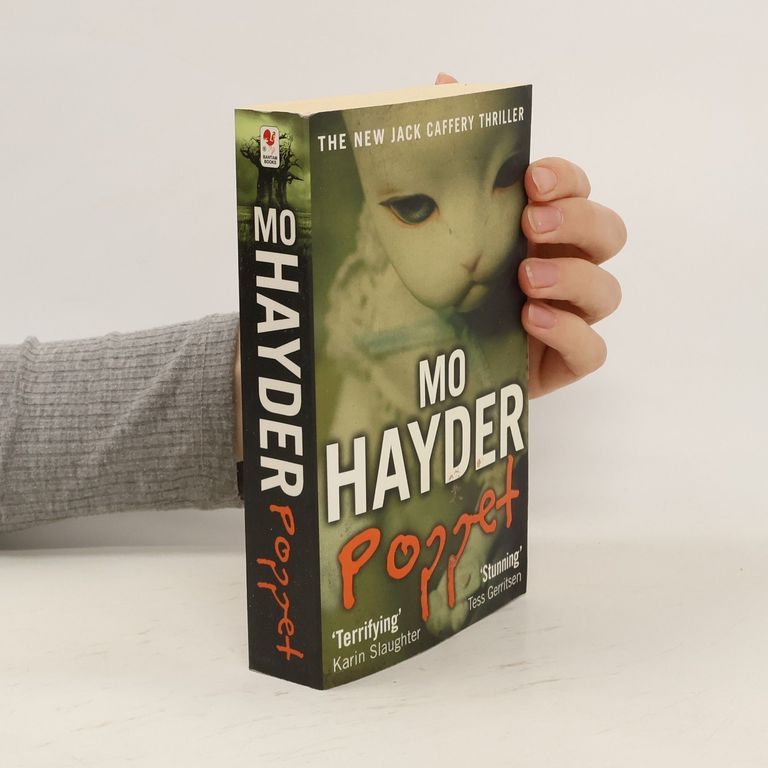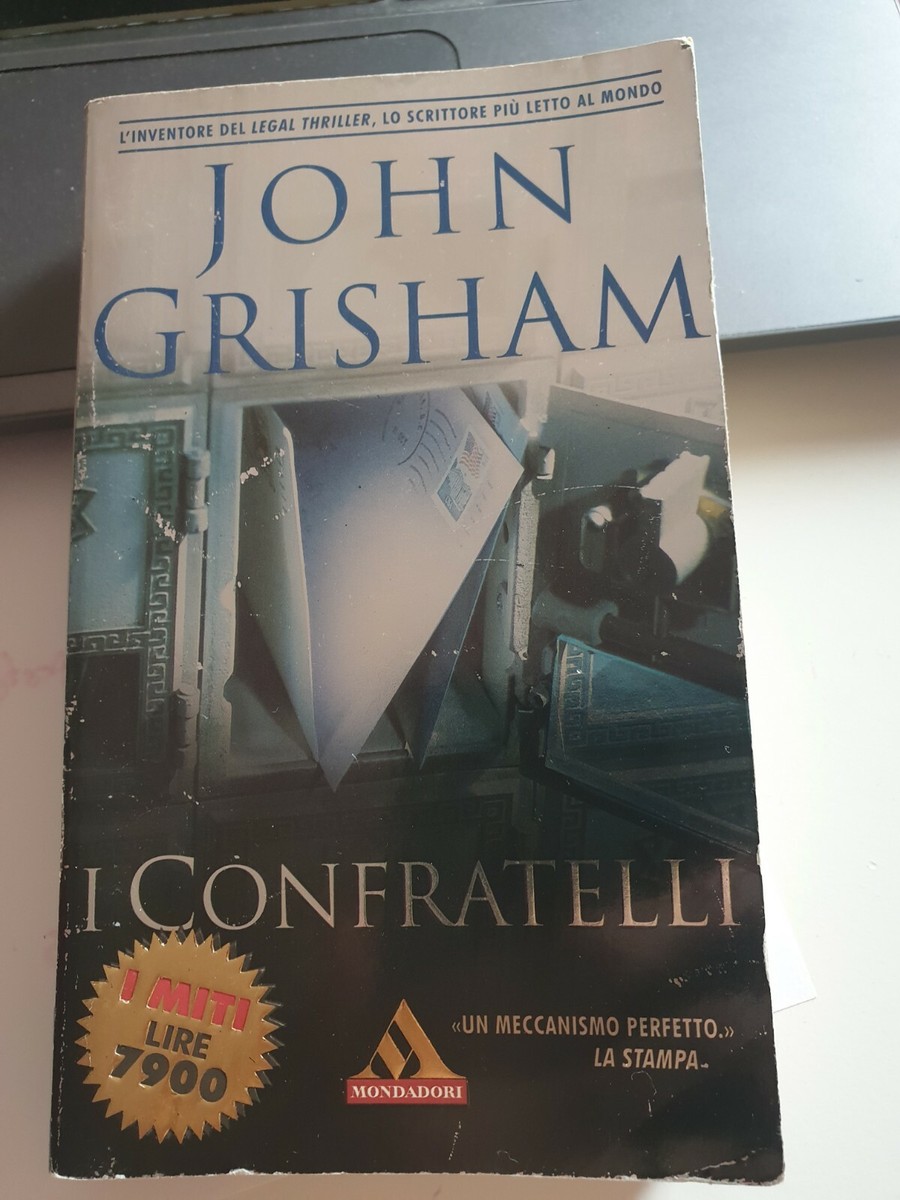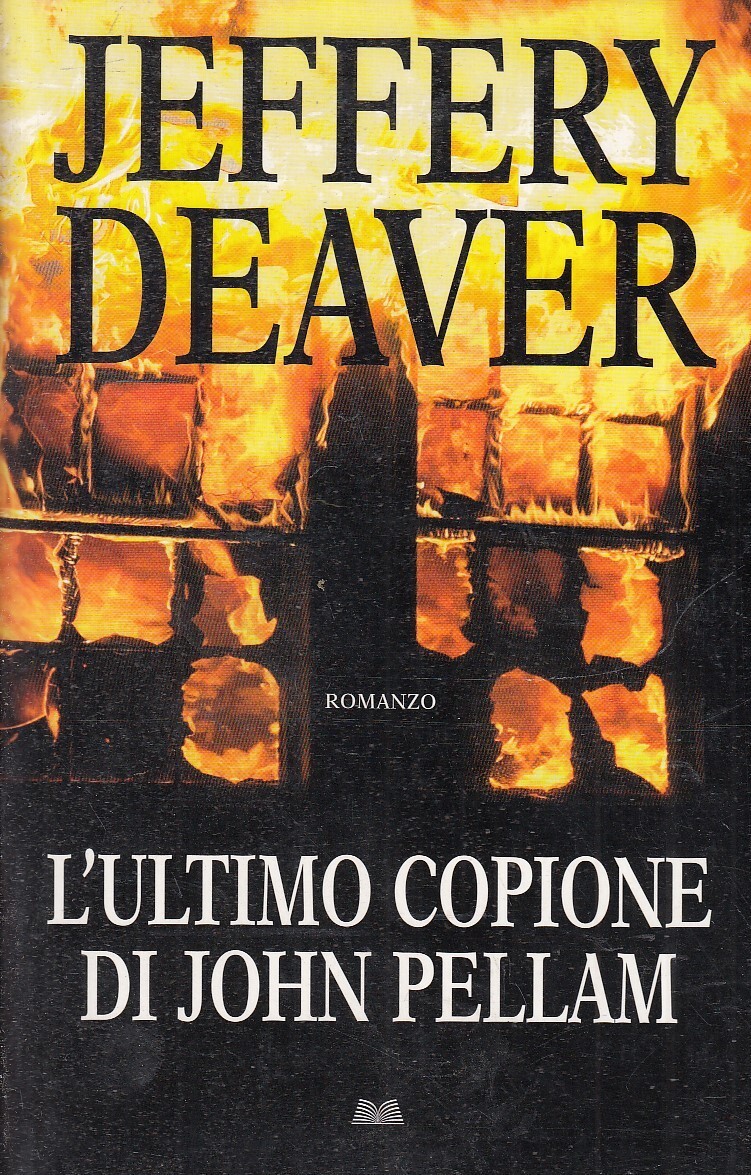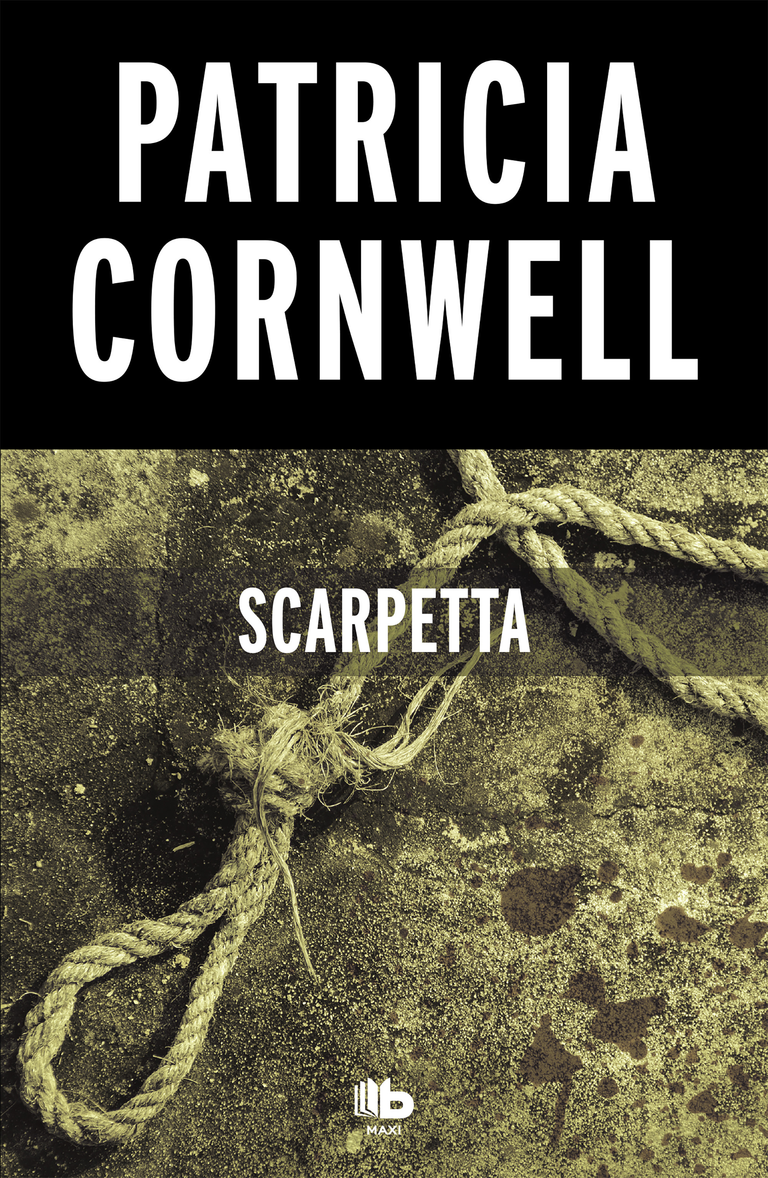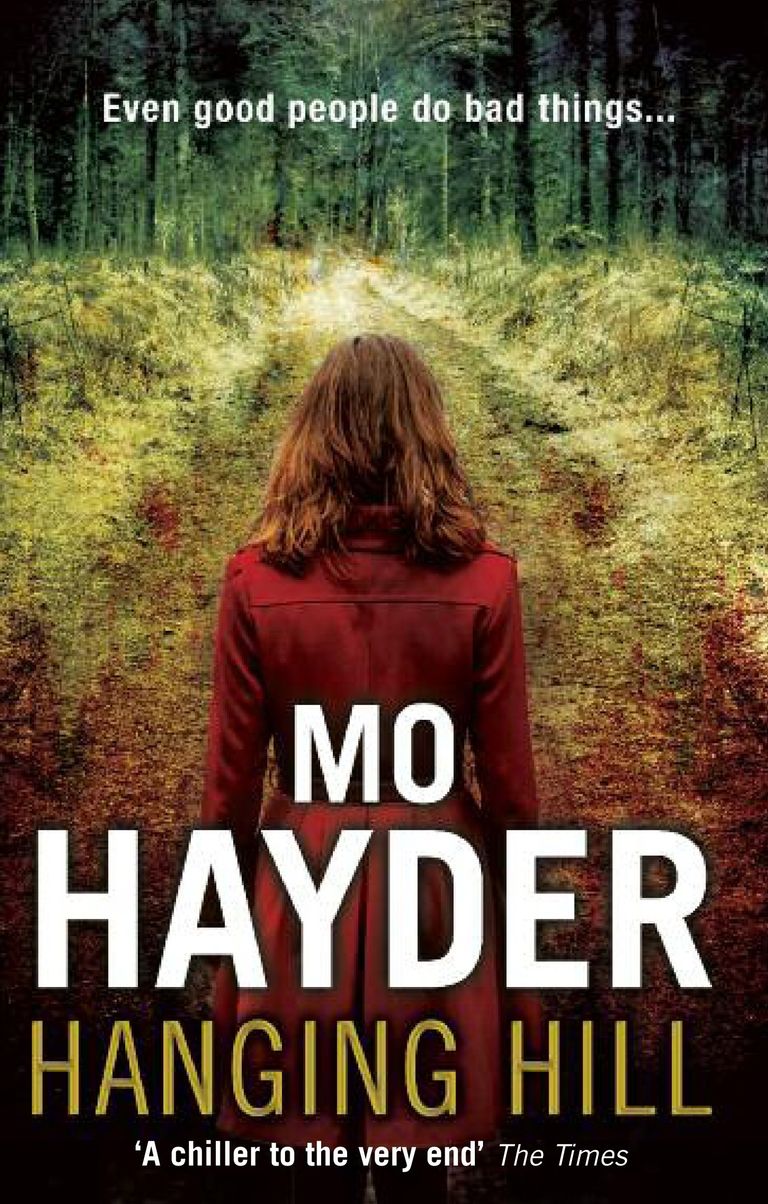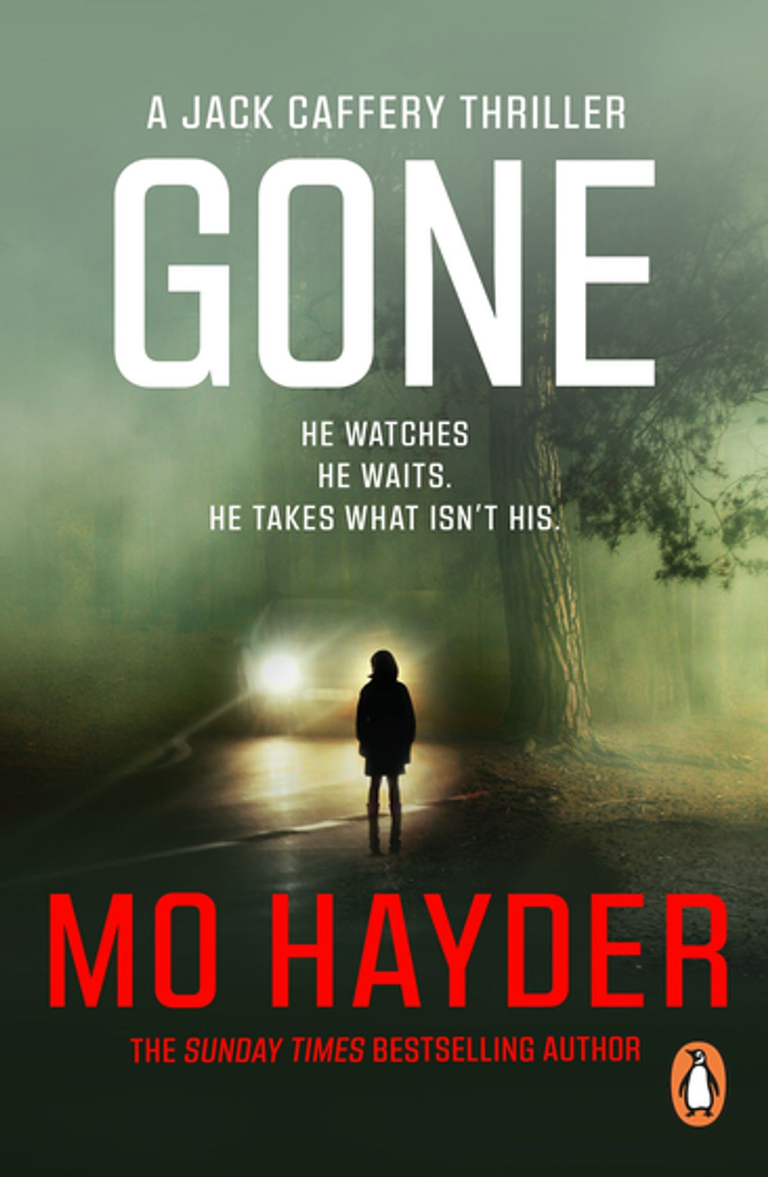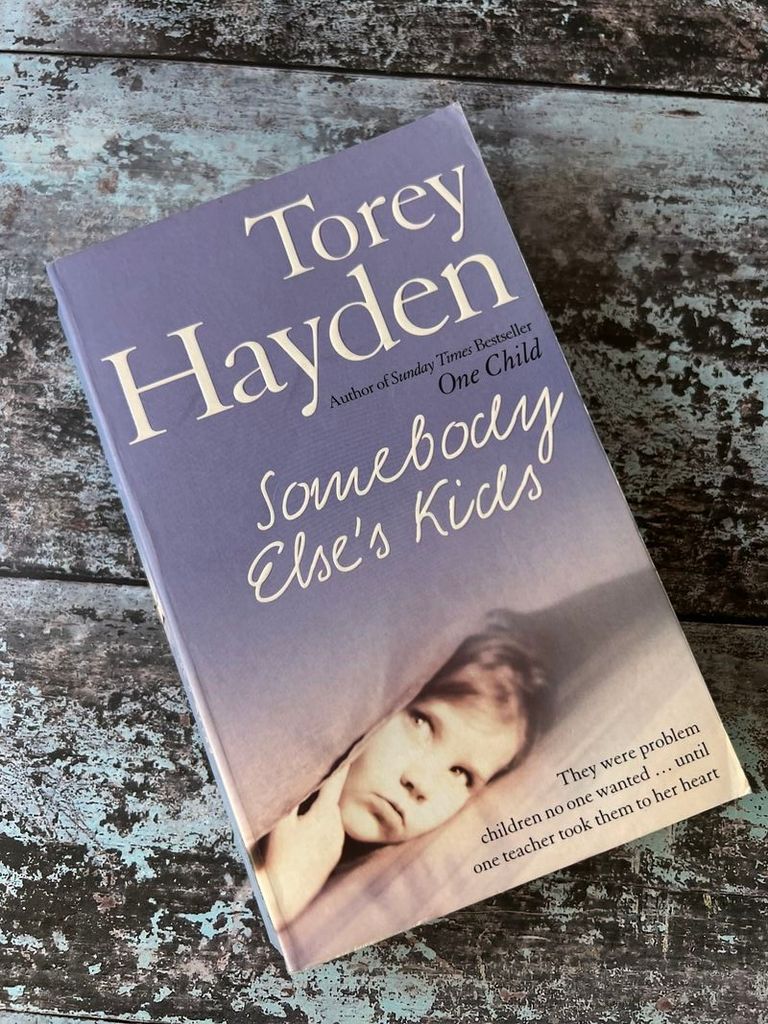Etichette:
Dramma,
Horror e Fantasy,
Robert McCammon
Jörmungandr, il serpente del mondo | Mitologia norrena | Il mio viaggio in
God of War (PS4)
-
La mitologia norrena, o molti dei suoi elementi, sono presenti in vari
videogiochi. Giochi come The Elder Scrolls: Skyrim presentano molti
elementi norre...